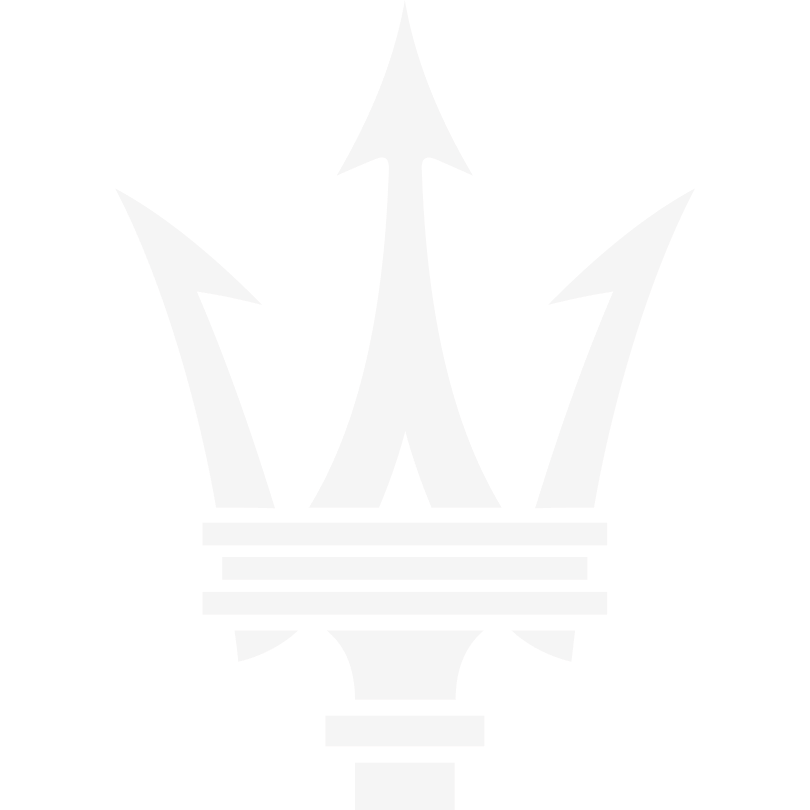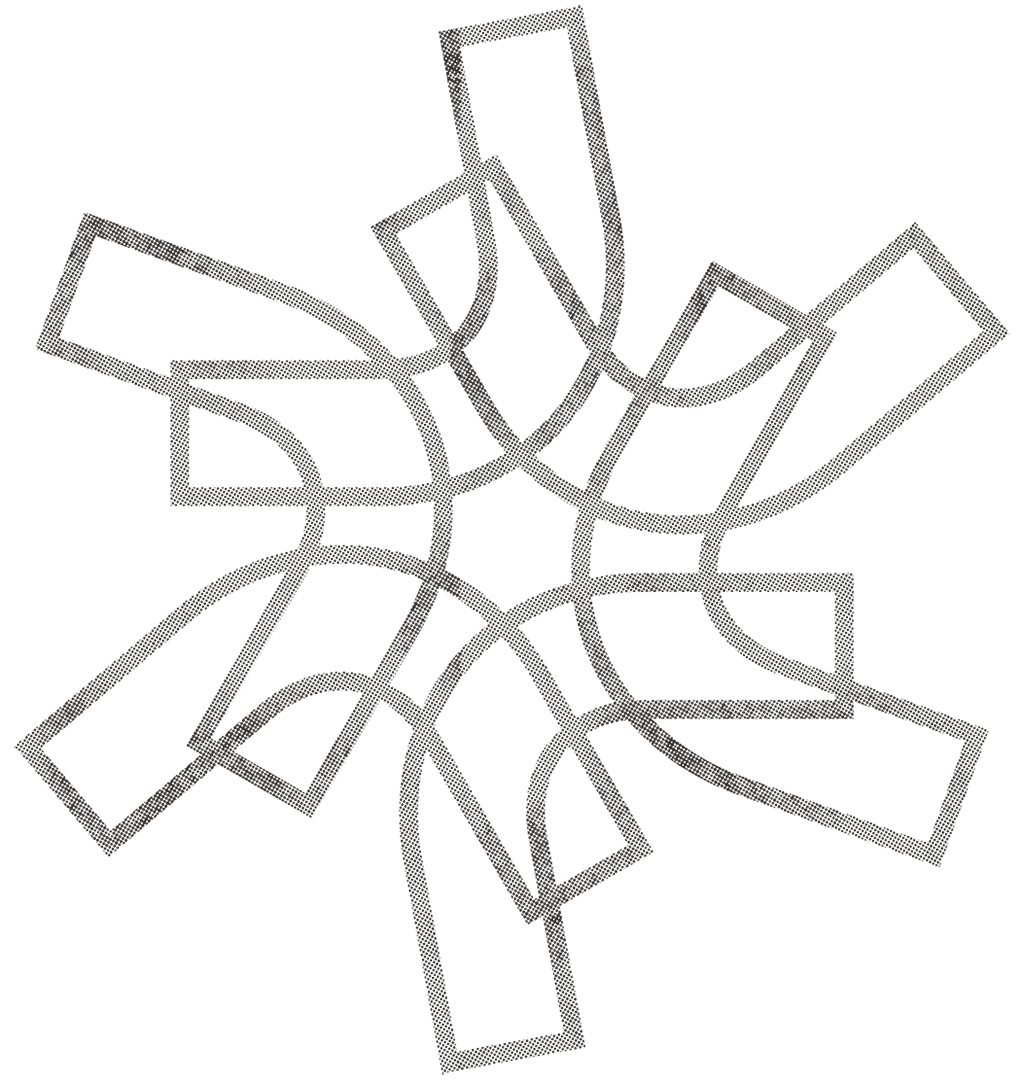LIFESTYLE | L’insostenibile leggerezza della moda
L’insostenibile leggerezza della moda
Le parole hanno una loro vita, un colore e un respiro. A volte, quando se ne fa un abuso o un uso distorto, perdono valore. Questo è successo a sostenibilità, il cui significato è all’origine del tutto nobile. Peccato che, strada facendo, in un mondo di eccessi nel quale viviamo, il termine sia stato talmente scritto e pronunciato da sfilacciarsi.
Di Renata Molho
Credo che il termine sostenibilità sia ormai il più citato dal marketing, dove ha sostituito parole come dinamismo e qualità. Un'ondata di greenwashing ha sommerso qualsiasi settore produttivo, anche quello petrolifero. L'ipocrisia è sottintesa e tollerata. Qualche tempo fa, ragionavo proprio di questo con Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food: “Il termine è molto chiaro, ma noi italiani dal punto di vista etimologico siamo quelli che l’abbiamo interpretato peggio di tutti: se chiedi a cento italiani che cos’è la sostenibilità, ti dicono che è qualcosa che può consentire un diverso approccio con la produzione, eccetera. Hanno ragione i nostri amici francesi che lo traducono in durable e non noi, che pensiamo che sostenibile sia una cosa che tutto sommato non distrugga l’ambiente. La durabilità, il reggere nel tempo significa che qualsiasi azione io faccio, devo farla in maniera tale che ne possano godere dei frutti anche le generazioni future. Viceversa – conclude Petrini – il nostro atteggiamento fino a ora non è stato questo: è egoistico credere che le risorse siano infinite, che quindi si possa prendere a man bassa. Ma siamo arrivati al punto che la finitezza delle cose ci obbliga a cambiare paradigmi. Se non cambiamo paradigmi, la sostenibilità è una parola vuota”.
Certo è che abbiamo un problema gigantesco, che dovrebbe mettere al centro discussioni sull'intero sistema capitalistico, sull'incapacità di controllare gli effetti collaterali della globalizzazione. Un problema che si fonda sul desiderio, sulla volontà di immaginare strategie di comunicazione che prevedono solo di persuadere, di indurre all'acquisto. Di infondere un senso di inadeguatezza che ci costringe a desiderare sempre di più, la t-shirt che non abbiamo ancora, il cappotto di quel colore visto nella pubblicità: proprio l'industria della moda, che sappiamo essere sostanziale per la nostra economia, gioca in questa dinamica un ruolo importante.
Negli ultimi vent’anni, la moda si è avvitata su sé stessa. Gli appuntamenti sono sempre più numerosi e ravvicinati. L'ossessione per la novità porta alla creazione di un tempo sfalsato e freneticamente accelerato. Un brand che aspira ai mercati internazionali deve tenere conto di variabili infinite. Non solo del gusto che, pur se va omologandosi, resta determinato da fattori culturali diversi, ma deve rispondere a latitudini e geografie distanti. La geopolitica, sempre più imprevedibile e liquida, confonde le idee e le consistenze. Tutti parlano simultaneamente a tutti: a un pubblico con esigenze infinitamente lontane.
Inoltre, l’esplosione del mercato della cosiddetta fast-fashion, la moda “usa e getta” economica e di tendenza ma estremamente inquinante, produce danni irreversibili. È nata per offrire agli strati meno abbienti della popolazione mondiale l'illusione di condividere con idoli fasulli, celebrity e influencer una certa estetica. Gli si offre la scia profumata del prêt-à-porter di lusso, di quello che si vede sui social o sulle poche riviste patinate che sopravvivono ancora. È un fenomeno imponente.
Gli abiti sono prodotti da colossi come H&M, Zara, Shein, con tessuti di bassa qualità, in paesi come Cina, Bangladesh, India, Pakistan e Vietnam, dove la manodopera è a basso costo e lavora con orari insostenibili e in condizioni di scarsa sicurezza. Difficile controllare la catena produttiva, che resta lunga e nebulosa. Un'infinita produzione di stracci che raggiunge Stati Uniti, Europa e Asia, dove vengono venduti a prezzi bassi per essere indossati poche volte. Solo in Europa si dismettono 2 milioni di tonnellate di prodotti tessili ogni anno. Secondo Oxfam, il 70% dei capi viene portato in Africa dove sarà rivenduto nei mercati locali. Gli abiti usati, che provengono anche dagli Usa e dal Giappone, rappresentano un’opportunità e una soluzione conveniente, ma danno luogo anche a una serie di gravi problemi ambientali ed economici. Il primo è lo smaltimento dell’invenduto e dell’invendibile. Impossibile stabilire con precisione quale sia l’impatto ambientale negativo.
Secondo il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, l'industria della moda è responsabile della produzione di circa il 10% dell'anidride carbonica globale e di un quinto dei 300 milioni di tonnellate di plastica prodotte ogni anno. Anche materie naturali, come il cotone, hanno un’impronta ambientale molto alta: Secondo il WWF, occorrono 2.700 litri d’acqua per produrre il cotone necessario per una sola t-shirt, senza calcolare l’uso massiccio di pesticidi e fertilizzanti nelle coltivazioni intensive. Esiste un cotone bio, prodotto con pochissima acqua e senza uso di sostanze tossiche, ma al momento rappresenta meno dell’1% della produzione mondiale. In quest’ottica, l’altra risposta per affrontare la crescente impronta ecologica negativa della moda è l'industria dei materiali di nuova generazione. Sono costruiti fermentando e coltivando sostituti a base biologica per i materiali di origine animale (come la pelle) e per quelli sintetici basati sui combustibili fossili (ad esempio, il poliestere). Alcuni di questi nuovi prodotti tessili bio possono essere progettati per offrire particolari performance, insieme a proprietà come la biodegradabilità. Stella McCartney, fin dai suoi esordi, ha adottato questi materiali innovativi per le sue collezioni: dalla pelle vegana (“animal & cruelty free”), al nylon e poliestere riciclati, fino al Bananatex o ai tessuti ricavati dalle alghe. Anche per la sua ultima linea P/E 2024, ci assicura che il 95% dei materiali usati sono “eco-conscious”.
In generale, l'adozione di pratiche sostenibili rappresenta una sfida. Tuttavia questo non significa che l'industria non sia aperta al cambiamento; al contrario. Negli ultimi anni, l'industria della moda è diventata più consapevole e ha iniziato ad affrontare il problema. Secondo il rapporto sulla sostenibilità di Launchmetrics, "Making Sense of Sustainability", realizzato in collaborazione con la Camera Nazionale della Moda Italiana, nel primo semestre del 2022 la moda ha generato un MIV (algoritmo che misura il Media Impact Value) di 618 milioni di dollari: l'industria della moda ha rappresentato un terzo delle conversazioni complessive sulla sostenibilità. Parole. A questo proposito, il Fashion Pact, nato nel 2019 in occasione del G7 per chiedere un cambiamento radicale dell’approccio della moda verso l’ambiente, conta oltre 200 marchi (tra i quali Chanel, Zegna, Ferragamo, Gruppo Armani, Gruppo Kering, Prada) che rappresentano tutte le segmentazioni di prezzo e circa un terzo dell'industria della moda: per ora, si segnalano solo grandi discussioni e ottimistiche roadmap. Solo greenwishing, con sporadici risultati concreti.
Qualche anno fa, in un'intervista, Carlo Capasa, Presidente della Camera della Moda Italiana, mi parlava con orgoglio del Green Carpet, l’evento internazionale sulla sostenibilità nella moda che, primo al mondo, dal 2017 vede protagonisti i brand più prestigiosi e virtuosi portando in scena personaggi dello spettacolo sensibili al tema, regalando un tocco hollywoodiano a Milano.
In occasione dell’ultima edizione del 2023, Gucci ha ricevuto l’“Ellen MacArthur Foundation Award for Circular Economy” per il suo Denim Project, che si propone di integrare nelle collezioni cotone proveniente da agricoltura rigenerativa con fibre post-consumo riciclate, raccolte e rigenerate in Italia; è stato introdotto anche un passaporto digitale che permetterà di tracciare il percorso dalla materia prima alla produzione.
A questo proposito, la Camera della Moda è da anni impegnata proprio nella creazione di questa “catena garantita”, o blockchain, che certifichi le varie fasi di produzione, “per avere la tracciabilità totale di un capo, come già avviene per il food”, spiega Capasa. Ma questo processo, già difficile per quanto riguarda prodotti molto costosi, non è immaginabile con capi dal costo troppo basso: "Il fast-fashion gioca un’altra partita”.
“La moda totalmente sostenibile è un’utopia”, ha dichiarato recentemente Giorgio Armani, aggiungendo però che “la sostenibilità è un’utopia con cui dobbiamo convivere. Per la quale dobbiamo lottare. Lo dobbiamo prima di tutto a noi stessi, al pianeta, e soprattutto alle generazioni che verranno. Un impegno con cui confrontarsi di continuo. Oggi si è consapevoli che il profitto per un’azienda non può più essere l’unico obiettivo”. Un pensiero affettuoso e di grande ammirazione va a Vivienne Westwood, anticipatrice e pioniera alla quale tutti, ma proprio tutti, devono molto in termini di ispirazione. È stata, in tempi non sospetti, una convinta attivista per l’ambiente. Suo il motto: Buy less, choose well, make it last. Siamo ancora lontani, ma, tra utopico ottimismo e cinico realismo, il tema è chiaro.